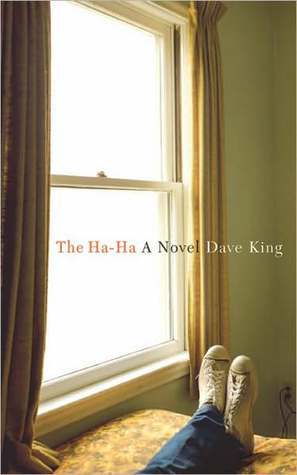Da lontano, non vedresti niente di complesso o di innaturale; c’è un adulto che sta badando a un bambino: magari, a poca distanza, c’è la sua compagna che sorride, e osserva la scena. Avvicinandoti, apprezzeresti qualcosa di radicalmente diverso. Quell’adulto ha una ferita antica sul cranio, e non parla: non scrive, non legge, non conosce il linguaggio dei segni. Mugugna, mima.
Quel bambino non è suo figlio, è il figlio d’una sua ex, del suo unico grande amore: gliel’ha affidato, ché si trova in clinica per disintossicarsi dalla cocaina. Quella donna che li osserva, invece, è l’affittuaria dell’uomo ferito; è sua amica, adesso, lo aiuta nell’amministrazione e nella quotidianità, come può.
Da lontano avresti pensato fosse una famiglia. Sembrava tutto così bello, e così naturale. Già. In termini botanici, questa stupenda illusione si chiama ha-ha. L’ha-ha è, tecnicamente, un muro nascosto da un fossato ricoperto d’erba. È un’illusione ottica: serve a offrire una vista idilliaca del panorama che circonda un giardino, dai prati e dai dintorni nobili d’una casa. L’etimo è curioso: spiega Thomas Everett, nella The New York Botanical Garden Illustrated Encyclopedia of Horticulture: “Il termine ha-ha deriva dall’esclamazione che un estraneo potrebbe lasciarsi scappare nel ritrovarsi improvvisamente sull’orlo del fossato dalla cima del muro. Un’esperienza di questo tipo, ovviamente, si rivelerebbe estremamente pericolosa per gli sprovveduti” (p. 11). Il lettore è avvisato.
Opera prima di Dave King, scrittore americano classe 1955, “The Ha-Ha” è l’ennesima storia di uno sfortunato reduce del Vietnam: Howard è rimasto ferito in missione, da allora soffre talvolta di alessìa (incapacità di riconoscere i segni della scrittura), di anomia (in accezione neurologica: incapacità di nominare gli oggetti, pur potendoli riconoscere), agrafia, formicolii e ammette di agire “non sempre” con cognizione di causa. Comunque: “La maggior parte degli uomini – delle persone – nella mia condizione è emotivamente instabile, e invece io sono il re del controllo e, nonostante sia un po’ lunatico, il mio è considerato un caso fortunato” (pp. 26-27). Non parla da tanti anni. Lavora come giardiniere in un convento, è mantenuto dal sussidio d’invalidità, ha smesso di drogarsi (inevitabilmente, ci pensa spesso). Grazie alla finzione letteraria, noi siamo nella sua mente: laddove i pensieri si sviluppano, fluidi e armoniosi, dolorosi e vivi, a dispetto della difficoltà di pronunciarli nella realtà. E quindi… siamo di fronte a una chiara contraddizione, o se preferite a un ossimoro strutturale: l’anomico Howard è il narratore. Racconta quel che non potrebbe comunicare se non mimando.
Non aspettatevi – è bene chiarire subito questo aspetto – una scrittura sperimentale e capace di rappresentare e scolpire i disturbi (anomalie o ritardi) del linguaggio come, per intenderci, avveniva nel magnifico “Fiori per Algernon” di Keyes: “Ha-Ha” è narrato da un cittadino disabile, non da un ritardato; con i personaggi ha difficoltà di interazione, non ne ha con noi lettori. Diciamolo: la finzione non è orchestrata con adeguate capacità persuasive; è evidente che l’escamotage studiato da Dave King poteva avere diversa credibilità fondandosi su una sobria narrazione in terza persona: narratore onnisciente, magari, ma extradiegetico. Invece, consci come siamo della malattia del personaggio-io narrante, troviamo curiosa e falsa questa condivisione totale – e scritta – della sua romanzesca vicenda. È un cortocircuito logico che ci spinge subito a concludere che l’autore Dave King non ha particolarmente a cuore certe questioni nucleari, come la logica della narrazione; vuole, piuttosto e molto semplicemente, raccontarci una storia edificante, umana e commovente; vuole giocare coi nostri sentimenti, vuole delectare ac movere, e magari docere. Con ogni mezzo. Diciamolo: siamo già dalle parti di Hollywood: l’adattamento cinematografico di questo libro strappacuore dovrebbe essere terminato nel 2008 (cfr. “The Ha-Ha”, di Tod Williams (?), 2008) e io credo che agli yankee piacerà (in ogni caso ne sapremo qualcosa anche da queste parti) più di quello derivato da “Un ragazzo” di Hornby.
Cos’hanno in comune i due romanzi? È presto detto. In entrambi i casi, un adulto “atipico”, pure per ragioni ben differenti, scopre la paternità trovandosi, più o meno volontariamente, un ragazzino difficile affidato; entrambi i ragazzini difficili hanno un curioso cespuglio di capelli ricci (in King il piccolo è proprio mulatto); in entrambi i casi la mamma del piccolo è in clinica (depressa in Hornby, drogata e caotica in King); in entrambi i casi, la soluzione dei contrasti interiori dei piccoli è affidata alla condivisione di un codice comune a quello del “nuovo padre”; in Hornby è musicale, qui è sportivo (baseball); infine, in entrambi i casi il rapporto tra i due adulti e le madri è infelice (non poteva essere altrimenti…). Ed ecco la differenza sostanziale; qui la madre è, come s’accennava, una ex speciale; è l’unica che ricorda Howard com’era prima della guerra, sano e forte, ed è l’unica donna che Howard sogna (a occhi aperti) e desidera (masturbazione inclusa); invece, in Hornby, è una figuretta che è semmai fonte di frustrazione per il figlio, che la vorrebbe vedere al fianco del “nuovo papà”. Ancora: in entrambi i casi, l’insegnamento è naturalmente mut(u)o e reciproco; il piccolo restituisce gioia di vivere e franchezza, l’adulto assicura, con la sola (r)esistenza, un modello e un paradigma, magari non fortunato né esemplare, di padre.
Morale della favola: due società molto simili, bianche e anglosassoni, che sembrano aver smarrito il ruolo del padre nelle famiglie, danno letture diverse dei difficili legami con le nuove generazioni. Testimoniando un difficile passaggio di consegne; caratterizzato da parecchi black-out, e da non poche incomprensioni. L’inglese Hornby mostra questo alter pater come un giovanotto involontariamente ricco, stravagante, superficiale e scapestrato: sotto, sotto è un cuore d’oro, che saprà redimersi dal cazzeggio e dall’ostilità nei confronti degli sfortunati. L’americano King mostra un alter pater malato, e compromesso, certo, ma non del tutto; generoso, buono e forte, magari un po’ stupido, sicuramente romantico. Ecco due archetipi dell’inglese borghese e dell’americano piccolo borghese, narrati incidendo ritratti di società in crisi, se non allo sbando. La Letteratura ci sta rivelando uno iato tra due generazioni: difficoltà di trasmissione di insegnamenti, valori, principi, modelli. Questi due esiti, “Un ragazzo” e “Ha-Ha”, sono dolorosi ma tutto sommato ottimistici. Meglio così. Chiara in entrambe le opere è una comune fonte di ispirazione, direi sociale e non letteraria; chiara, e senza dover forzare particolarmente la mano, mi sembra sia la lettura allegorica.
Il lettore s’attenda, da questo romanzo di King, 60 capitoli (oltre 450 pagine) di un ipertrofico canovaccio cinematografico; generose dosi di sentimentalismo e di malinconia (la ferita del Vietnam è una frattura irrimediabile, ma gli States sono ancora in piedi: istupiditi ma orgogliosi), di un’impossibile e tuttavia dolcissima paternità, di una magnifica vivacità in un ambiente tenuto vivo dalla presenza di questo grosso muto, che va mulinando amore a bracciate, e ritrova il gusto della vita in questo bambino.
Non mancheranno ostacoli di vario genere, è chiaro: litigi, discussioni, addirittura la polizia tra i piedi per una forte incomprensione, il manicomio sfiorato per un niente (ci pensano le suore del convento), violenze… il tutto, intervallato da dettagliate memorie dell’incidente al fronte e della riabilitazione, amarcord lisergici e nostalgie per mai ultimati restauri in casa e via dicendo. Quei lettori che vorranno appassionarsi al gran cuore di Howard, e all’enorme artificio di Dave King, non rimarranno delusi dai vari subplot.
Certo, che questo sconfitto e malato reduce dal Vietnam, infine, s’innamori (o giù di lì!) d’una affittuaria dagli occhi a mandorla… questa sì che è una metafora interessante, e fertile di sviluppi letterari interessanti e non poco. Ne parleremo in occasione del prossimo libro di questo autore; quando decifreremo meglio se si gioca al politicamente corretto o se si sta suggerendo un messaggio politico chiaro. Fin qua, preferisco Dickens. Sia a Hornby che a King.